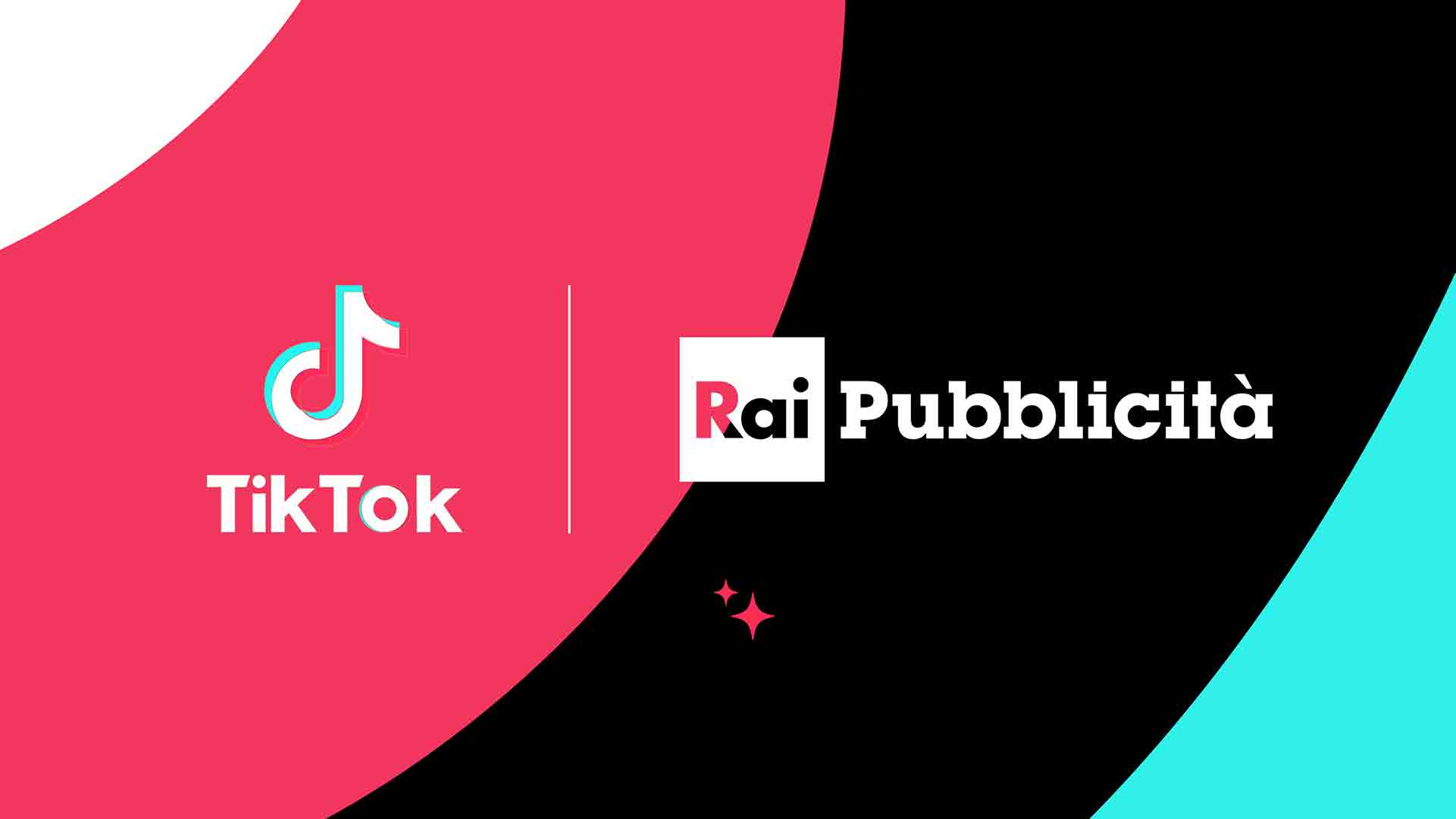La SEO non morirà mai: storia di una disciplina che tiene in ordine il caos del web
La search engine optimization odierna serve e servirà a costruire contenuti contestualizzati oltre che leggibili sia da esseri umani sia da sistemi automatizzati. Nessuna intelligenza artificiale, per quanto evoluta, è in grado di valutare con certezza l’affidabilità di una fonte senza l’aiuto di segnali esterni

Nel 1996 bastava fare molto poco per comparire in cima ai motori di ricerca. Era l’epoca delle directory, dei meta tag scritti a mano e dell’illusione che internet fosse uno spazio neutro, libero e incontrollato. Da allora, la SEO ha attraversato almeno cinque grandi trasformazioni e si è adattata ogni volta ai cambiamenti tecnologici, culturali e cognitivi del web. Chi ne annuncia ciclicamente la fine, dimentica un punto fondamentale: la search engine optimization è una disciplina che media tra l’enorme produzione di contenuti online e la necessità umana di orientarsi in mezzo a tutto questo e, con l’arrivo dei motori di ricerca basati sull’intelligenza artificiale, dei modelli linguistici di grandi dimensioni e della generazione automatica di contenuti su vasta scala, l’esigenza è più viva che mai. Diventa quindi importante affidarsi a un professionista esperto e riconosciuto, come per esempio si può fare sul sito lauraventurini.it: i benefici sono molteplici e, tra i vari, vi è la possibilità di poter contare su qualcuno che conosca i cambiamenti del web e che sappia volgerli a proprio favore.
L’era primitiva della SEO: keyword stuffing, meta tag e cloaking
Tra il 1994 e il 1996, la SEO era un’attività quasi artigianale. I primi motori di ricerca, come Architext, poi AltaVista e infine Google (nato nel 1998), si limitavano a leggere i meta tag, i titoli delle pagine e la densità delle parole chiave. Non esistevano ancora penalizzazioni strutturate: bastava ripetere la stessa parola chiave più volte o usare il cloaking (mostrare un contenuto al motore e un altro all’utente) per scalare le classifiche. Con il tempo, però, i criteri di indicizzazione si fecero più sofisticati: si iniziò a tenere conto dei link in entrata, della struttura del sito, della presenza di sitemap, e dell’uso corretto degli attributi semantici nel codice HTML. Fino al 2010, molte tecniche manipolative (black hat) come il keyword stuffing o le link farm continuarono a funzionare e a essere largamente utilizzate. La svolta avvenne con gli aggiornamenti Panda (2011) e Penguin (2012), con cui Google cominciò a penalizzare attivamente contenuti duplicati, siti di bassa qualità, link sospetti e strategie di manipolazione del ranking. Da quel momento in poi, la SEO cambiò pelle: da tecnica manipolativa diventava un’attività basata sulla qualità, sull’affidabilità e sull’esperienza utente.
Web 2.0, user-generated content e sovra-produzione informativa
L’avvento del Web 2.0, a partire dal 2004, segnò un punto di svolta. L’utente evolvette da spettatore ad autore. Nascevano WordPress, Blogger, e successivamente Facebook, YouTube, Medium e Reddit. I contenuti si moltiplicarono, il tempo medio di permanenza sui siti diminuì, e gli intenti di ricerca diventarono più articolati. Google introdusse Hummingbird (2013), il primo algoritmo che valutava le query in base al contesto semantico e all’intento dell’utente, anziché sulla sola corrispondenza delle parole. Nacquero concetti chiave come search intent, topic clustering e contenuto cornerstone. Contemporaneamente, i SEO iniziarono a lavorare su nuove dimensioni: UX, tempo di caricamento, ottimizzazione mobile, segnali comportamentali. L’ottimizzazione on-site non era più sufficiente da sola: la SEO diventava cross-canale e sempre più connessa al content marketing.
L’età della post-verità, del ranking zero e dell’intelligenza artificiale
Con l’esplosione dei social e la diffusione della disinformazione, il ruolo della SEO cambiò ancora. Google lanciò i criteri E-A-T (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness), poi aggiornati in E-E-A-T, secondo i quali i contenuti più attendibili sono quelli scritti da persone reali, con competenze verificabili e fonti attendibili. Nel frattempo, sono entrati in scena strumenti come ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini, che hanno ridotto drasticamente il tempo tra domanda e risposta. L’utente pone una query e riceve un riassunto: non clicca, non naviga, non approfondisce. Il traffico verso i siti è diminuito, ma è aumentata la necessità di strutturare informazioni affidabili alla fonte, per evitare che le AI si nutrano di contenuti errati o approssimativi.
Perché la SEO è ancora (e sarà sempre) necessaria
Contrariamente a quanto si sente dire, l’intelligenza artificiale non elimina il bisogno di SEO, anzi, lo radicalizza. Se ogni giorno vengono prodotti milioni di contenuti, in automatico, senza controllo, senza verifica, qualcuno dovrà pur stabilire cosa è degno di emergere; non per manipolare i risultati, ma per rendere l’informazione utile, reperibile e navigabile. La SEO odierna serve e servirà a costruire contenuti contestualizzati oltre che leggibili sia da esseri umani sia da sistemi automatizzati. Il motivo? Nessuna intelligenza artificiale, per quanto evoluta, è in grado di valutare con certezza l’affidabilità di una fonte senza l’aiuto di segnali esterni, quali la coerenza del contenuto, la struttura del sito, i link ricevuti da fonti autorevoli ecc, ossia le attività tipiche della SEO che, oggi, non serve più soltanto a "farsi trovare", ma a entrare nel ciclo di apprendimento e selezione delle AI stesse.